Si usa dire che una crisi è un’occasione troppo buona per essere sprecata. Figuriamoci una Grande Crisi come quella che l’Occidente ha appena attraversato e sta ancora attraversando. Eppure, secondo Paul Roberts, questa volta l’abbiamo buttata via: in fondo, dice il giornalista-saggista, siamo rimasti smithiani, anzi immersi nel trionfo individualistico spiegato da Adam Smith più di due secoli fa. Nella lettura del mondo proposta da Roberts in un libro appena pubblicato — The Impulse Society, la società dell’impulso — siamo entrati nell’era in cui il mercato è diventato una cosa sola con la nostra individualità, in cui l’impulso personale è immediatamente soddisfatto da Apple o da Netflix, da una carta di credito o da una app. La manifestazione della libertà, scrive, s’è concretizzata in «una società plasmata dai nostri impulsi». Pessimo, a suo avviso, perché «un’economia riorientata a darci quello che vogliamo, si scopre, non è la migliore per fornirci ciò di cui abbiamo bisogno». Nemmeno la Grande Crisi che ha fatto vacillare questo modello — stabilisce — ha corretto la tendenza.
Roberts dice di non volere criticare l’efficienza in quanto tale. Piuttosto, è critico radicale dell’ideologiadell’efficienza: di quel «credo, sacro nella politica contemporanea e specialmente nel business, secondo il quale la maggiore produzione al costo più basso dovrebbe sempre essere il fine della società » (corsivo suo). Per contrastare questa ricerca della soddisfazione immediata degli impulsi e la logica del breve termine che ne consegue dovremmo puntare a un «capitalismo alternativo». Roberts si dice scettico circa modelli autoritari come quello cinese o dalla mano pesante sul genere di quelli di India, Brasile, Indonesia. Eppure, considera che «queste società hanno come minimo cercato di fare sì che le loro economie le portassero in direzioni specifiche, all’opposto del seguire semplicemente la direzione in cui l’ideologia dell’efficienza guida. Hanno deliberatamente definito il successo economico e la ricchezza in termini sociali espliciti».
Nella cultura politica corrente in Occidente, o almeno in America, è impossibile cambiare paradigmi, ammette Roberts (che nel 2004 pubblicò un saggio non esattamente profetico sulla «fine del petrolio»). Dice di essere partito nell’analizzare la situazione con idee ancorate a sinistra ma di essere arrivato alla fine del suo lavoro a «conclusioni che sono distintamente conservatrici»: famiglie forti, comunità intatte, apprezzamento di virtù come l’autodisciplina, «essenziali per mantenere una società stabile e sostenibile». Chi vuole cambiare, dunque, oggi deve stare «da qualche parte nel mezzo», tra i poli della destra e della sinistra e rifiutare l’economia moderna, che per soddisfare gli impulsivi bisogni individuali starebbe distruggendo la fabbrica della società.
Il manifesto elaborato da Roberts non è nuovissimo. Certo, individua disagi che tutti viviamo: il frequente senso di ingiustizia; i desideri di consumi che si possono definire superflui; legami comunitari spesso sfilacciati; l’impressione che non ci sia un fine in esistenze modellate dal consumismo; il disorientamento verso innovazioni di prodotto che modificano usi e comportamenti consolidati; tweet che sembrano cancellare non solo l’informazione ragionata, ma anche il modo di accostarsi alla cultura. È una critica morale al capitalismo del XXI secolo, soprattutto a quello di matrice angloamericana. Ma, in fondo, parte da constatazioni già espresse da altri.
Nonostante questo, la critica che porta al modello attuale di capitalismo ha un piede nei rivolgimenti non minimi in corso nel mondo. Ed è così radicale da richiedere, nel caso se ne vuole discutere, di uscire in effetti dai paradigmi dominanti. Per dire: dal dibattito sulla necessità di una preminenza del mercato o dello Stato o sui punti deboli di un capitalismo oligopolistico in cui i rapporti incestuosi tra big business e governi e burocrazie spingono all’annullamento della competizione di mercato. Roberts va oltre. Per esempio, individua nella decisione della General Motors, nel 1926, di introdurre il cambio di modello annuale delle auto un punto di svolta per la produzione di massa: il presidente della Gm, Alfred Sloan, volle non più solo miglioramenti tecnologici, come freni più sicuri, ma anche novità «cosmetiche o stilistiche intese a dare una gratificazione emotiva». Si iniziava a vendere lo status alle masse, linea che troverà un momento trionfale nell’economia dell’impulso di oggi, nella soddisfazione immediata dei desideri. La critica, insomma, riguarda almeno un secolo di capitalismo e arriva al Suv, che, oltre a essere un simbolo di status, ha un contenuto aggressivo: «Riduce sostanzialmente le vostre probabilità di essere feriti durante un incidente ma raddoppia le chance che le persone che coinvolgete siano ferite o uccise».
Da questo punto di vista, il libro di Roberts è stimolante: parla con una voce che di solito non si fa sentire, quella dei critici radicali delle nostre società, che rifiutano di misurarsi sui grandi dibattiti del momento, ovviamente interni all’accettazione del capitalismo. È il punto di vista, se si vuole, di un antagonista, in effetti più conservatore che progressista. E, come spesso capita in una cornice del genere, è confuso tra critica della modernità e importanza di remunerare meno i top manager.
I punti deboli di Roberts sembrano essere due. Il primo sta proprio nel fatto che le sue analisi e proposte sembrano improponibili nell’attuale panorama politico ed economico, come egli stesso ammette. Il secondo, più profondo, sta nella vecchia idea che gli individui in fondo non siano in grado di scegliere e che dunque qualcuno dovrebbe, se non decidere per loro, guidare l’economia in modo da non lasciare tutte le libertà di scelta di oggi. Molti concorderanno con lui: la tecnologia e l’economia moderna spesso disorientano e il capitalismo attuale non di rado sembra poco aperto e molto burocratico e statalizzato. Buone ragioni per dire che è meglio essere meno liberi di scegliere? Mah: ci vorranno molte, molte Grandi Crisi per riuscire a dimostrarlo.
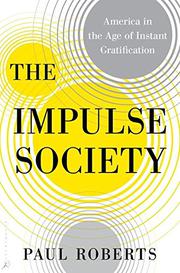
Nessun commento:
Posta un commento